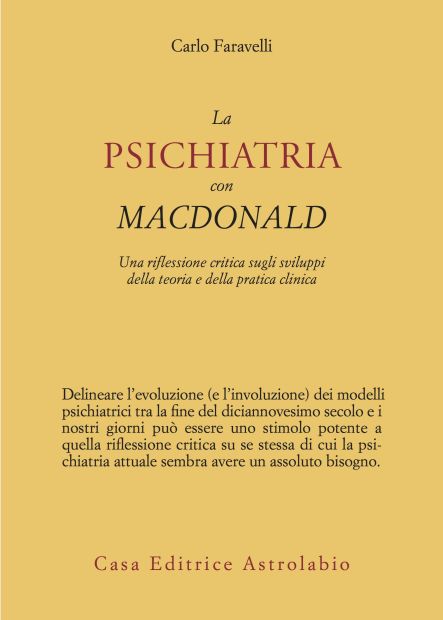
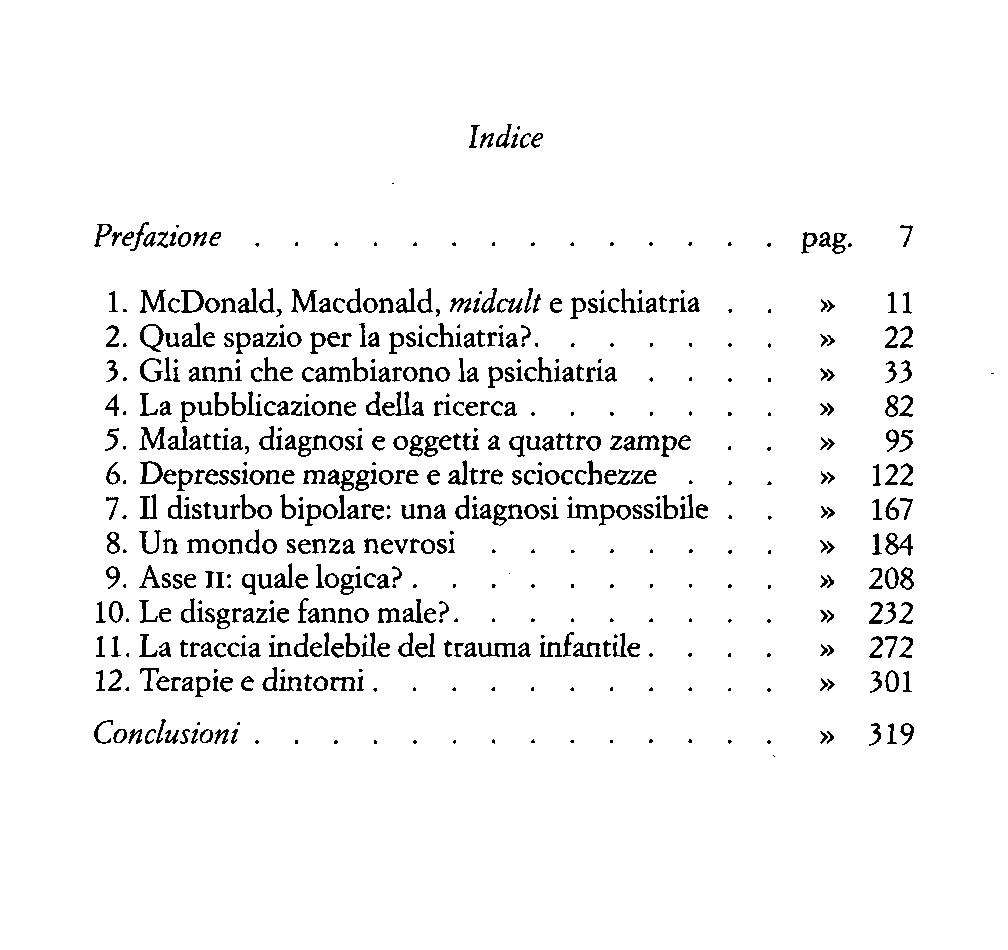
Cap. 1 Macdonald, McDonald, Midcult e psichiatria
L’accostamento della psichiatria con McDonald/Macdonald può suscitare perplessità. In effetti si parla solo di Psichiatria. Per la maggior parte delle persone il nome ‘McDonald’ ricorda la nota organizzazione di ristorazione, diffusa in tutto il mondo per affidabilità, sicurezza, garanzia di uniformità riguardo al cibo proposto. Non certo, diranno gli estimatori della buona cucina, per le qualità gastronomiche. ‘Macdonald’ (scritto in modo diverso), invece, è il cognome di un filosofo e sociologo americano, Dwight Macdonald (1906-1982), oggi meno conosciuto rispetto a qualche decennio fa, che ha illustrato con largo anticipo l’impoverimento del clima culturale americano successivo alla Seconda guerra mondiale. In questo senso ho voluto tracciare il parallelismo tra l’evolversi della psichiatria e l’evoluzione della ristorazione, entrambe nel contesto del cambiamento del clima culturale degli ultimi 50 anni. Da una tradizione illustre di medici-filosofi, abilissimi osservatori e narratori, ma lontani dall’uniformità clinica e diagnostica, un po’ troppo narcisisticamente compiaciuti di se stessi, al progressivo spostamento verso una psichiatria fatta di crocette sui questionari, ben stabilita, riproducibile, facilmente accessibile e comprensibile, ma straordinariamente povera di costrutti epistemologici, oltre che di profondità psicopatologica. Dall’altra parte una ristorazione che è andata sempre più verso il fast food e la massificazione del gusto. Nel mezzo, come elemento unificante, vero artefice di entrambi i cambiamenti, l’ingresso sempre più massiccio del mercato dell’interesse economico, teso ad allargare quanto più possibile il plateau dei fruitori di qualsiasi prodotto commercializzabile, sia esso la cultura, l’arte, il cibo, lo spettacolo e anche la psichiatria. Sentii parlare per la prima volta di Dwight Macdonald, quando ero ragazzo, attraverso il libro di Umberto Eco Apocalittici e Integrati (1965), che peraltro già nel primo saggio “Cultura di massa e ‘livelli’ dicultura” espone con la consueta chiarezza e capacità critica il nocciolo dell’argomento.
Macdonald (Masscult and Midcult, 1960, tradotto in italiano da E/Onel 1997, e più recentemente, da Piano B ed., Prato 2018)) si allaccia al dibattito nato in Inghilterra tra le due guerre, sulla degenerazione del gusto nella middle class. Già Virginia Woolf, la scrittrice, tra le prime, aveva fortemente criticato il travisamento della cultura operato dal fenomeno detto middlebrow, parola che, come aggettivo, può essere tradotta‘facile da capire’ e anche, come sostantivo, ‘persona di cultura media’. Riprendendo il filo di questa impostazione, Macdonald la lega all’evoluzione economica del Novecento. L’aumento del numero di persone le cui possibilità non erano più interamente assorbite per la sopravvivenza ha fatto sì che parte del surplus economico fosse dedicata a cultura ed arte. Tuttavia, la genuinità dell’interesse, la competenza e ,soprattutto, il bagaglio culturale di base non erano tali da permettere di fruire appieno dei significati della cultura e dell’arte. Nel contempo, però, la quantità di denaro che essi introducevano in questi mercati non poteva essere trascurata. Se questa nuova moltitudine era in grado di recepire ad arte e cultura solo nei loro aspetti più semplici e superficiali, la forza economica di questo nuovo mercato, a sua volta, era tale da indirizzare parte dell’arte e della cultura verso le forme di più facile fruizione. Veniva quindi a prendere forma la ‘cultura di massa’ (masscult). La vera cultura (highbrow) è quella della persona genuinamente eprofondamente interessata agli oggetti di studio: come scrive Umberto Eco, “la cultura alta era rappresentata, tanto per capirci, da James Joyce, Marcel Proust, Pablo Picasso, mentre quello che veniva chiamatomasscultera dato da tutta la paccottiglia hollywoodiana”. La lowbrow (che potremmo oggi tradurre “cultura popolare”) comprende prodotti idonei alla popolazione meno colta, sul solco delle tradizioni popolari, comunque non modificati ad hoc per scopi commerciali, quindi ancora genuini. La cultura di massa, invece, prende sia dalla cultura popolare che, in parte, dall’alta cultura, ma li trasforma in prodotti banali, manipolati e pronti all’uso, in cui eventuali residui di profondità culturale sono impietosamente impoveriti. Questi sono dedicati all’intrattenimento e al profitto che da questo deriva, sono quindi soggetti alle leggi del mercato (modernamente a sua maestà l’audience). A differenza dei prodotti della cultura, ad essi non si richiede di risvegliare alcuna scintilla nel fruitore, anzi ogni stimolo all’introspezione deve essere abolito. Macdonald pensa che queste forme non meritino l’attribuzione deltermine cultura, e preferisce denominarle masscult.Il prodotto masscult deve principalmente essere di facile assimilazione, non importa se vivace o soporifero. Non chiede nulla al fruitore, se non un po’ di attenzione, perché non richiede alcuna risposta, nemmeno quella emotiva. Allo spettatore non chiede nulla e non dà nulla, non può indurre alcuna modificazione perché il prodotto della masscult è già tagliato a immagine dello spettatore, “completamente soggetto allospettatore”. Come è oggi usuale, il compito dell’intrattenimento è quello di trattenere lo spettatore (televisivo in questo caso) tra uno spazio pubblicitario e l’altro.Tutto questo, al contrario della cultura alta, che stimola il pensiero del singolo e quindi il pluralismo di idee, contribuisce ad accrescere sempre più il livellamento verso il basso. Il midcult delinea invece un terzo livello intermedio, emerso con lacultura , meno rozzo e molto più sottile rispetto al masscult, ma anche più infido e travisante. Qui la cultura alta non è ignorata, anzi: i contenuti, le parole, le citazioni provengono per lo più da questo settore. Ma si tratta in realtà di un travestimento, di un prendere a presto temi genuinamente culturali, per utilizzarli in contesti inidonei, e in persone prive del background e della curiosità proprie dell’uomo di cultura. È talvolta una conoscenza indiretta, attraverso strumenti di divulgazione (è in auge nell’epoca di Macdonald il Reader’s Digest), si tratta della ricezione superficiale di nozioni non comprese fino in fondo, non assimilate, ma soprattutto non assimilabili perché precotte e preconfezionate. La midcultsi ammanta di cultura alta, la cita, la esalta, la venera, ma in realtà la espropria, la svilisce, la contamina di piattezza, “spargendo ovunque il suo tiepido velo fangoso” che minaccia l’alta cultura.Nel masscult “il trucco è scoperto”: l’obiettivo è dichiaratamente il grande pubblico e i temi sono scelti in funzione del gradimento per quanta più gente possibile, con ogni mezzo; il tranello del midcult, invece, non è immediatamente individuabile. Il midcultadotta i temi, leparole, i modelli dell’alta cultura, ma li banalizza, li storpia, li costringe all’impoverimento. Questo aspetto di pseudocultura che si presenta come facente parte dell’Alta Cultura, porta con sé una pericolosaambiguità. Questi elementi del pensiero di Dwight Macdonald (che io ho qui presentato in maniera approssimata, impoverita, certamente cadendo nel midcult, dato che non sono un sociologo), rivisitati oltre 60 anni dopo, sono ancora illuminanti. Per un verso essi hanno preconizzato ciò che sarebbe accaduto in misura ancor più vistosa nei decenni successivi, per un altro sembrano superati dall’inondazione odierna della masscult, che ai prodotti storici dell’intrattenimento ha aggiunto i contenuti incontrollabili dei social network. La midcult, invece, ha, a mio avviso, conservato la maggior parte dei caratteri descritti da Macdonald. Si tratta ancora di utilizzare termini, concetti, intuizione, tradizioni dell’alta cultura svuotandoli, del tutto oin parte, degli attributi fondamentali, riducendoli a prodotti più facilmente fruibili, ma in realtà sostanzialmente diversi da quelli originali. Per McDonald (quello degli hamburger) il processo di omogeneizzazione del prodotto per incontrare il gusto dei clienti è scoperto, il successo è stato evidente ed ha portato altre catene di ristorazione ad uniformarsi allo stile McDonald. Come in molti altri campi, anche qui l’alta cultura (alta cucina nello specifico), tesa a esplorare nuovi campi, a proporre sapori nuovi e diversi, e quindi a educare il pubblico a sperimentare, è stata (parzialmente) sostituita dal suo opposto: una cucina tutta uguale che tende a uniformare i gusti.
La tesi di questo volume è che nella psichiatria sia successo qualcosadi analogo, ma molto meno evidente, interamente nell’ambito del midcult, e quindi ambiguo, nascosto. Nella fattispecie, all’aspetto di culturadi medio basso livello si appaia l’aspetto di scienza di basso livello.
Romolo Rossi (2010) sostiene che non è tanto la psichiatria ad essere cambiata, bensì lo psichiatra. Essendo la psichiatria una materia priva di un suo statuto scientifico autonomo, essa inevitabilmente si modella sui suoi cultori, i suoi professionisti, i suoi divulgatori. Rossi propugna una sorta di evoluzione “darwiniana” dello psichiatra, descrivendo le tappe del cambiamento attraverso la delineazione di passaggi progressivi della tipologia delle diverse “specie” (Rossi sottolinea con l’uso di“specie” il parallelismo con Darwin) di psichiatra. Confrontiamo il primo caso, lo psichiatra narratore, archetipo dello psichiatra, con uno degli ultimi di quelli descritti da Rossi con le parole dell’autore:
“Lo psichiatra narratore. Da quello che si è detto, era ovvio che sipartisse da qui, dallo psichiatra-Balzac1[…] Questa istanza narrativa diminuisce intanto la durezza del lavoro […], aumenta la gradevolezza della ricerca, aumenta l’autostima. Ma soprattutto fornisce un livello di stabilità dato che, operando prevalentemente nella fantasia narrativa, diminuisce fortemente l’insicurezza legata alla debolezza dello statuto scientifico, anche se questo vantaggio viene pagato con l’esigenza di qualità narrative ed impressionistiche più elevate e complesse di quelle del ricercatore. Lo psichiatra narratore è persona di molte ed estese letture, ed ha di solito un notevole grado di cultura letteraria: come potrebbe scrivere se non leggesse? Ed infatti egli è di solito un pregevole scrittore ed un capace descrittore, che tramite immagini, metafore, parole pregnanti, sa evocare stati d’animo, emozioni, idee, deliri,comportamenti, riuscendo a chiarire strutture psicopatologiche che la convenzione non illumina. [Pag. 6] Rossi prosegue riportando due brani di Minkowski, considerato l’alto esponente di questo tipo di cultura psichiatrica. Questo romanziere è considerato da Rossi l’esempio di narratore dei sentimenti umani più vicino alle esigenze della psichiatria.
All’estremo opposto, sintesi dello psichiatra moderno, c’è lo psichiatra iperdiagnosta:
“Lo psichiatra iperdiagnosta. […] tende ad accettare senza riserve,anche se si sforza di mantenersi critico, il dato consolidato da un libro, che egli non considera il prodotto di una onesta ma pur sempre discutibile ricerca di un gruppo di lavoro, bensì una sorta di testo di riferimento senza il quale la diagnosi non è valida, aiutato dal fatto che difficilmente le accreditate riviste internazionali accetterebbero un lavoro senza a diagnosi del DSM. […] Dunque,questo psichiatra moderno segue l’ultimo manuale dell’AmericanPsychiatric Association e lo considera un trattato. Ciò che si pone fuori di esso tende ad essere scotomizzato, o ignorato, o, se si preferisce, negato […] aumenta l’uso di termini come borderline, doppia diagnosi, bipolare, disturbo delirante, mentre termini come schizofrenia ebefrenica o catatonica si riducono, e nessuno di questi psichiatri parlerà mai di erotomania di De Clérambault o did elirio dei falsi riconoscimenti di Sérieux e Capgras, data la fuga dall’eponimo, eponimo che quando rimane viene anch’esso rimpicciolito e banalizzato, così come Gilles de la Tourette che diventa per il DSM IV un borghesissimo Tourette. Questo serve solo, qui, a rendere l’idea delle tendenze banalizzanti di questo psichiatra: l’ipotesi di base rimane quella genericamente neurobiologica,ma molto lontana […]. I prototipi e i rappresentanti illustri di questa specie sono moltissimi, e si potrebbero citare i membri della Task Force del DSM,anche se questa psichiatria attira fortemente i più giovani, per un certo grado di facilitazione e di agevolezza che produce, data la linearità e semplicità dei suoi assunti. [Pagg. 12-13]
Nelle descrizioni di queste due ‘specie’ di Psichiatra (il secondo tratteggiato impietosamente) non si ritrovano forse gli aspetti più esemplificativi della high culture (nello psichiatra narratore) e della midcult nellopsichiatra iperdiagnosta?Rossi ha portato l’esempio di Minkowski come narratore, per suggerire il confronto tra psichiatri di epoche diverse. Il confronto però è ingiusto: da una parte l’élite, grandi pensatori e grandi scrittori che ci sono stati tramandati perché fuori dell’ordinario, dall’altra una visione contemporanea non selezionata e inserita in un contesto che obiettivamente chiede cose diverse. Tuttavia, se si vanno a leggere gli stessi argomenti, scritti durante le due epoche, si trova la differenza non tanto nelle capacità narrative, quanto nel diverso anelito verso l’esplorazione, la scoperta, l’interpretazione dei fatti psichici. Si leggano la trattazione dell’allucinazione, per fare un esempio, in Minkowski o in Jaspers, e po ile trattazioni contemporanee (v. Faravelli e Lai 2003). I primi, filosofi a tutti gli effetti, tesi alla comprensione del fenomeno, le seconde volte aduna descrizione, peraltro corretta e generalmente completa, ma priva di genuina curiosità intellettuale. La trattazione delle allucinazioni dà un chiaro esempio del modo di essere e di pensare della psichiatria della prima metà del XX secolo. Visione olistica, integrazione (peraltro non sempre riuscita) di filosofia, psicologia, neurologia, capacità di osservazioni finissime e dettagliate del fatto clinico e interpretazioni raffinate e profonde che spesso finiscono per perdere l’aderenza con l’esperienza clinica reale. Una psichiatria colta, antropologica, globalizzante, sostanzialmente umanistica, certamente con un po’ di autocompiacimento. Se si confronta questo tipo di trattazione con quelle analoghe di un trattato moderno, specie se nordamericano, si coglie subito la differenzatra le due psichiatrie. Corposa, nobile, penetrante, ma probabilmente esercizio fine a se stesso quella di Minkowski, e forse anche di Jaspers, asettiche, descrittive, forse un po’ superficiali quelle successive ai DSM. Se, come sostiene Rossi, è lo psichiatra che cambia, e la psichiatria cambia di conseguenza (come negarlo?), che cos’è che determina il cambiamento dello psichiatra, se non gli stessi processi che Macdonald ha individuato nella nascita del midcult? Fino ai primi anni 60 anni la psichiatria era confinata in un ambito marginale della medicina, che faceva fatica ad accettare questa disciplina così peculiare come parte di sé. Non a caso la psichiatria si era dovuta fondere con la neurologia (Neuropsichiatria o Malattie Nervose e Mentali) per avere qualche riconoscimento. L’impatto della psichiatria sul mercato economico era trascurabile, se non per la spesa sostenuta per i manicomi. I profitti, relativamente piccoli, riguardavano la poca professione privata, soprattutto le psicoterapie.La scoperta prima, e lo straordinario successo degli psicofarmaci poi, ha convogliato sulla psichiatria una grande quantità di denaro. Inevitabilmente gli strumenti del mercato si sono rivolti a questo settore, forzando il cambiamento da un sapere apollineo, profondo, ma inutilmente complicato e difficilmente espandibile, verso modelli più accettabili, più lineari, più semplici. Ma soprattutto più indirizzabili. Cioè più manipolabili, più atti a essere dati in pasto ai pazienti, al pubblico, ai prescrittori, agli organi regolatori. Quindi sfruttabili in termini economici. Anche qui evidente vicinanza ai modelli di Macdonald e di Eco. Questo è il processo che, a mio avviso, ha più profondamente influito sul divenire della psichiatria. Una corsa all’obiettivazione i cui i dettami epistemologici fondamentali della scienza empirica (Karl Popper, per capirci) sono stati utilizzati in forma attenuata, travisata, piatta, in ultima analisi midcult (siveda il cap. 5).Dalla necessità di presentare sempre nuovi farmaci per un mercato assetato nascono le scale di valutazione, le diagnosi riproducibili. Da qui i criteri operazionali, le nuove classificazioni e i DSM, dal III in poi. Corollari inevitabili di ciò, vengono le interviste strutturate, le linee guida, i protocolli terapeutici. Qualche esempio di uso immiserito della cultura? I creatori del DSM III definirono questo sistema kraepeliniano e ateorico. In realtà esso seguiva il pensiero di Kraepelin solo per quanto riguarda la classificazione delle psicosi, e in questo neanche fedelmente. Mancava però il vero substrato innovativo di Kraepelin, la sua scelta di privilegiare il decorso rispetto ai sintomi delle malattie. Per quanto concerne i principi basilari della classificazione, gli estensori del DSM III (come i loro successori) ne sembrano del tutto alieni. Eppure, pochi anni prima era stato dato alle stampe un pregevolissimo volume, estremamente esplicativo sul tema (Kendell, 1975). D’altra parte, per quanto riguarda la conoscenza delle tassonomie, non si dimentichi che per un verso gli anni in cui Kraepelin si è formato (fine Ottocento) sono quellidella grande attenzione al naturalismo, e che il fratello di Kraepelin, Karl (1848-1915), era un ricercatore affermato in campo zoologico, direttore del Museo Naturale di Amburgo e autore di contributi importanti nella classificazione degli animali.
La scelta di essere ateorico ha di fatto portato il DSM all’effetto opposto. Una classificazione priva di un presupposto teorico è una di quelle situazioni in cui il non scegliere è di per sé una scelta importante. Non sipuò non scegliere se farsi la barba o no: nel frattempo la barba cresce. Immaginate di riordinare qualcosa (una stanza, un magazzino, uno scaffale, il contenuto del frigorifero, qualsiasi cosa vi venga in mente) rinunciando programmaticamente a qualsiasi principio organizzatore! Fin dalla sua uscita, il DSM III ha stupito per la sua mancanza di radici e per la sua proposta di una psichiatria così semplicistica. Proprio per la sua scelta di essere ateorico e di volersi staccare dai principi tradizionali, il DSM III si è rivelato straordinariamente rivoluzionario. Oltre al principio di individuare nei sintomi manifesti l’unico indicatore dei processi patologici, l’abolizione delle Nevrosi, la creazione dell’asseII e tante altre cose hanno cancellato con un colpo di spugna una evoluzione pluricentenaria, riportando la classificazione ai tempi precedenti Sydenham (1624-1689), che concepì la malattia non solo come insiemedi sintomi, ma come complesso stabile nel tempo. Con il DSM III si ritorna ai concetti della Scuola medica di Cnido (V secolo a.C.), quando le malattie erano la febbre, gli esantemi, eccetera. Dopo aver contrabbandato per pensiero kraepeliniano una semplificazione priva di fondamenti teorici, nella psichiatria si è assistito all’adozione di una semeiotica (le interviste strutturate) che ha ignorato non solo tutti gli scritti sul colloquio psichiatrico, ma anche le nozioni elementari di psicologia della conoscenza. Si è pensato, secondo l’empirismo naif della tabula rasa, che l’osservazione potesse essere fatta senza una preconoscenza della cosa da osservare, cosa negata da oltre un secolo (Hanson 1918). Le classificazioni, l’individuazione dei singoli disturbi (anche l’adozione del termine disorder- tradotto come ‘disturbo’- non trova una giustificazione fondata), la misurazione, l’adozione di metodiche proprie della medicina organica senza una adeguata organizzazione epistemica, sono tutte questioni che saranno trattate in questo volume sotto la luce critica di una fondazione culturale e scientifica insufficienti. Un dettaglio: I primi quattro DSM erano contrassegnati in numeri romani, la quinta edizione adotta il numero arabo. Pare che la numerazione romana stia scomparendo dalla cultura occidentale (non soloamericana). Il Louvre ha abbandonato i numeri romani per indicare i secoli, mentre recentemente (2021) anche il museo Carnavalet, sulla storia di Parigi, ha detto addio ai numeri romani “perché possono essere un ostacolo alla comprensione”. Esempio palese che è la cultura chedeve abbassarsi per essere compresa, invece di chiedere ai fruitori di elevarsi. Negli Stati Uniti si celia che la numerazione romana sia usata solo per eventi di straordinario rilievo, come le guerre mondiali e il superbowl. Ma per il cinquantesimo superbowl si usò “50” perché “L”sembrava troppo difficile per i cultori del football.Posso aver dato l’impressione di un nostalgico della vecchia psichiatria, un estimatore del passato. Dato che ormai ho un’età venerabile esono in pensione da tempo è logico aspettarsi un laudator temporis acti se puero (Orazio, Ars Poetica). Può darsi che sia così, anche se questi temi erano già presenti nei miei articoli giovanili. In realtà, paradossalmente (anche se tanto paradossale non è), la psichiatria si è giovata di questa ipersemplificazione, uscendo dal limbo di pseudoscienza di nicchia che le veniva riservato nel passato, per diventare un settore straordinariamente diffuso. La psichiatria attuale, con tutti i limiti che ho indicato e che indicherò nel prosieguo di questo volume, è infinitamente superiore a quella che ho trovato quando mi sonoaffacciato a questa disciplina 50 anni fa. Come riferisce Eco, anche nella cultura massificata esistono dei vantaggi. Di alcuni di questi gli psichiatri hanno sicuramente usufruito:
–esiste uno standard professionale minimo accettabile, accessibileanche agli psichiatri di livello medio basso, mentre lo psichiatra ignorante di una volta era veramente e pericolosamente incapace;
–esiste una internazionalizzazione del settore, che fa uscire dal provincialismo misero e limitato che ho conosciuto gli inizi della miaprofessione;
–la conoscenza di dati di ricerca internazionali oggettivi, anche se con i limiti che saranno discussi, pone lo psichiatra mediamente informato al riparo dagli eccessi di soggettivismo tanto frequenti una volta, quando bastava dire “penso che…” o “nella mia esperienza…” per sostituire le nozioni provenienti dalla ricerca;
–l’accesso ai mezzi di informazione e aggiornamento professionale è facile per tutti (questo anche grazie alla diffusione di quegli stessi mezzi di comunicazione -internet in particolare- responsabile dell’appiattimento del sapere psichiatrico);
–la probabilità che ha oggi un paziente psichiatrico di riportare benefici molto consistenti dal trattamento è infinitamente più alta rispetto a 50 anni fa;
–l’accesso dei pazienti alla psichiatria, straordinariamente demonizzata nei secoli, è notevolmente migliorato, con conseguente diminuzione dello stigma associato alla malattia mentale.
D’altra parte, anche il fast food alla McDonald’s qualche nota positiva la ha, e devo confessare che varie volte, specie nei viaggi, mi ha risolto qualche situazione disagiata. Del resto, non penso che McDonald’s sia di qualche nocumento alla cucina “stellata”, di cui non mancano certo gli estimatori. È sulla trasposizione di questo punto alla psichiatria (forse alla medicina) che ho qualche dubbio. È mia convinzione che l’appiattimento e la accettazione di alcune convenzioni (una sorta di “politicamente corretto” nella scienza) limiti molto la possibilità di divulgare nuove idee.
Ultimo punto che mi ha spinto ad affrontare gli argomenti qui trattati è la necessità di una continuità storica, o almeno la preservazione della memoria. Per gli psichiatri di oggi sembra che la psichiatria sia nata con il DSM III e la scienza medica iniziata con PubMed. Eppure, esiste una tradizione importante, portatrice di posizioni e impostazioni diverse da quelle di oggi, abbandonate non perché superate e non più valide, bensì perché le esigenze del cambiamento del clima culturale generale ha reso un altro tipo di psichiatria più appetibile e più consono al contesto generale. In questo non è estraneo l’impatto economico, come già accennato. Penso che la testimonianza di chi ha vissuto entrambe le psichiatrie, possa essere di ausilio per gli psichiatri figli del DSM III, così come ogni incentivo alla riflessione critica.
Eco U. Apocalittici e Integrati Bompiani, Milano 1965
Macdonald D., Masscult and Midcult, in Partisan Review, XXVII, n. 2, primavera 1960, pp. 203-233,
Macdonald D., Masscult and Midcult, in Partisan Review, XXVII, n. 4, autunno 1960. Trad it Masscult e Midcult, in Claudio Gorlier (a cura di), Controamerica, Milano, Rizzoli editore, 1969, pp. 19-83
Faravelli C., Lai M. in: Smeraldi E: Rileggendo Minkowski. Excerpta Medica Italia, Milano. Pagg 192-198, 2003)
Kendell: RE The role of diagnosis in Psychiatry, Blakwell, Oxford 1975, Trad it. Il ruolo della diagnosi in Psichiatria, P.B.N. 1977
Rossi R, sottovoce agli psichiatri, Piccin, Padova 2010
Hanson N.R. The logic of discovery, Journal of philosophy, 1918, cit da Gialrdello G.: Filosofia della scienza e storia della scienza nella cutura di lingua inglese. In Geymonat :, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Vol IX, Garzanti 1972
Minkowski E. Traité de Psychopatologie, Presses Universitaiers de France, Paris 1966. Trad, it Trattato di Psicopatologia, Feltrinelli, Milano 1973